L'altra sera, durante una delle ultime lezioni del corso in un gruppo di livello A2, è successo un episodio molto simpatico con due studenti come protagonisti: un ragazzo e una ragazza. Gli alunni stavano facendo un esercizio orale di tipo grammaticale, dove l'attenzione era focalizzata sulle espressioni di tempo che si possono utilizzare quando raccontiamo un fatto al passato; era il turno del ragazzo che ha voluto rispondere non solo con l'espressione di tempo ma anche con il verbo al passato prossimo, sbagliando il verbo ma adoperando correttamente l'avverbio di tempo. La domanda era:
- Quando è stata l'ultima volta che sei andato al mare?
- * Ho andato al mare l'estate scorsa.
Io non ho detto niente (premetto che l'attività era corale) e la ragazza, guardandomi ha detto *Ho andato? Si dice Sono andato!. Io ho ricordato la finalità dell'esercizio e siamo andati avanti.
Quando il turno è ricaduto sul ragazzo, lui, facendo ricorso a tutte le conoscenze della sua grammatica (della sua interlingua) ha risposto alla domanda:
- Quando è stata l'ultima volta che ti sei arrabbiato?
- Mi sono arrabbiato domenica sera.
Non vi sembra meraviglioso? La voglia di superazione con un input adeguato non ha limiti!
Confronto di esperienze di insegnamento tra professori di italiano a studenti spagnoli e latinoamericani.
Persone interessate
30 jul 2012
23 jul 2012
Volare e l'interlingua
Continuando con le riflessioni sulla correzione degli errori c'è un manuale sul mercato che molti di voi conoscerete: Volare. Corso di italiano. Libro per lo
studente di Piero Catizone, Christopher Humphris e Micarelli Luigi,
Alpha & Beta (4 volumi, il volume I, edito nel 1997). Questo manuale, senz'altro rivoluzionario, risponde a una metodologia molto ben precisa e spiegata dagli autori in tutti i dettagli nell'Introduzione di ognuno dei libri.
Loro si basano sul concetto di interlingua, ovvero la lingua utilizzata da ogni singolo studente che non è più la propria lingua madre ma neanche la lingua d'arrivo e quindi, piena di errori e inferenze ma sono le conoscenze in costante evoluzione che l'alunno possiede e sulle quali il docente deve lavorare. L'interlingua è tutto quello che lo studente conosce e non conosce, ciò che è capace di saper fare e tutto ciò che non è ancora in grado di utilizzare.
Gli autori di Volare hanno saputo perfettamente elaborare un manuale che rispetta in tutto e per tutto, l'interlingua degli studenti di italiano.
È un manuale che, confesso, non mi sono mai azzardata ad adoperare nella sua totalità nelle mie lezioni perché avevo paura che gli studenti spagnoli che frequentano la scuola dove insegno rifiutassero un manuale di questo tipo dove non ci sono tabelle grammaticali né esercizi tradizionali.
Ma dopo le ricerche sull'uso cotidiano della lingua del metodo comunicativo e le riflessioni sulla persona dell'approccio umanistico-affettivo, la scoperta dell'interlingua e un manuale come questo hanno rappresentato per me un totale cambiamento di rotta nel mio modo di insegnare italiano.
Qualcuno di voi conosce questo metodo? L'avete mai adoperato?
Loro si basano sul concetto di interlingua, ovvero la lingua utilizzata da ogni singolo studente che non è più la propria lingua madre ma neanche la lingua d'arrivo e quindi, piena di errori e inferenze ma sono le conoscenze in costante evoluzione che l'alunno possiede e sulle quali il docente deve lavorare. L'interlingua è tutto quello che lo studente conosce e non conosce, ciò che è capace di saper fare e tutto ciò che non è ancora in grado di utilizzare.
Gli autori di Volare hanno saputo perfettamente elaborare un manuale che rispetta in tutto e per tutto, l'interlingua degli studenti di italiano.
È un manuale che, confesso, non mi sono mai azzardata ad adoperare nella sua totalità nelle mie lezioni perché avevo paura che gli studenti spagnoli che frequentano la scuola dove insegno rifiutassero un manuale di questo tipo dove non ci sono tabelle grammaticali né esercizi tradizionali.
Ma dopo le ricerche sull'uso cotidiano della lingua del metodo comunicativo e le riflessioni sulla persona dell'approccio umanistico-affettivo, la scoperta dell'interlingua e un manuale come questo hanno rappresentato per me un totale cambiamento di rotta nel mio modo di insegnare italiano.
Qualcuno di voi conosce questo metodo? L'avete mai adoperato?
17 jul 2012
La correzione degli errori
La correzione degli errori in una classe di lingua a stranieri da parte dell'insegnante o dai compagni di classe provoca non poche frustazioni ad alunni che ritengono che l'errore sia un punto di arrivo e non di partenza, quindi, come un fallimento. La maggior parte di noi abbiamo vissuto a scuola momenti di grande frustazione quando ci veniva consegnato il compito pieno di correzioni in rosso con il rimprovero più o meno tacito che si leggeva negli occhi della maestra. Per fortuna gli ultimi studi in glottodidattica e le apportazioni dell'approccio umnistico-affettivo nell'insegnamento delle lingue ritengono l'errore come parte necessaria e, per tanto fondamentale, del processo di apprendimento. Non bisogna vergognarsi di sbagliare, anzi, l'errore fornisce (all'insegnante e allo studente) un'informazione di prima mano per continuare a lavorare e a imparare.
Vi suggerisco di leggere questo articolo sulla correzione degli errori, di Christopher Humprhris e vi consiglio anche di visitare il sito web di un altro esperto in glottodidattica: Marco Mezzadri e leggere (tra gli altri articoli), "La correzione degli errori".
Untitled Document
Vi suggerisco di leggere questo articolo sulla correzione degli errori, di Christopher Humprhris e vi consiglio anche di visitare il sito web di un altro esperto in glottodidattica: Marco Mezzadri e leggere (tra gli altri articoli), "La correzione degli errori".
7 jul 2012
Come, quando e cosa correggere?
Come e cosa correggere? Secondo la mia esperienza, la
correzione dell’insegnante è l’azione che più segni lascia sui nostri studenti,
in bene e in male, è il nostro “marchio”: questo è giusto / questo è sbagliato.
Dunque, dobbiamo essere estremamente puntigliosi nella scelta dei criteri con
cui correggiamo perché influiremo in un modo determinante sull’adeguata (o inadeguata)
progressione del processo d’apprendimento dei nostri studenti.
Essere sempre consapevoli degli obiettivi del corso, di ognuna delle unità didattiche, di ciascun'attività ci permetterà di
sapere esattamente cosa vogliamo dai nostri alunni in ogni momento e in ogni fase del processo d’apprendimento.
Facendo una riflessione su cosa chiediamo allo studente ogni
volta che gli proponiamo un’attività, automaticamente dobbiamo riflettere su
come lo correggeremo quando la svolgerà. Non è sempre facile non perdere di
vista questa prospettiva: molto spesso dimentichiamo che l’obiettivo
finale è che i nostri studenti siano in grado di comunicare in italiano nella
forma più corretta possibile ma… non subito, non sempre, non dopo 30 ore di
lezione. E abbiamo la “umana” tendenza a correggere tutto o quasi
tutto. Farlo però risulta controproducente in quanto, paradossalmente, ostacola
il miglioramento. Perciò risulta indispensabile avere una
panoramica completa degli obiettivi da raggiungere per dosare nel migliore dei
modi le conoscenze, abilità e competenze che i nostri studenti devono acquisire
e apprendere.
Se volete, lasciate il vostro commento e come procedete voi, anche qual è stata la vostra esperienza come alunni!
Se volete, lasciate il vostro commento e come procedete voi, anche qual è stata la vostra esperienza come alunni!
30 jun 2012
Esame sì o no? (continuazione...)

Continuo a riflettere sulla necessità o, per meglio dire, l'utilità dell'esame in un corso di lingua. L'opinione di Vanessa ha fatto che il mio rifiuto innato verso l'esame sia un po' meno categorico...
È vero che potrebbe essere utilizzato come uno strumento che servisse per evidenziare i punti forti (importantissimo per l'autostima) e anche i punti deboli (quali aspetti bisogna rafforzare) e quindi l'esame diventerebbe uno strumento didatticamente valido come indicatore dei passi a seguire nel processo d'apprendimento.
È anche vero che ci sono studenti (come Vanessa) che l'esame lo vedono come una sfida e altri che lo ritengono una tortura (sicuramente a causa di brutte esperienze in passato). Il nostro compito consisterebbe dunque trasmettere ai nostri alunni una visione positiva dell'esame filtrando tutti gli aspetti negativi; un modo per far esperimentare sensazioni positive sarebbe proporre agli studenti dei piccoli test alla fine di ogni unità didattica con l'obiettivo di ridurre l'ansia e lo stress. Come sempre, se noi siamo convinti della necessità di qualcosa, trasmetteremo molta più convinzione! Se l'alunno che ha i sudori freddi alla sola idea dell'esame vede che quando gli viene restituito non c'è solo la correzione in rosso per la risposta sbagliata ma anche in verde per la risposta giusta, e che l'insegnante non evidenzia soltanto quella sbagliata, la percezione cambia molto, non credete?
23 jun 2012
100 gesti della lingua italiana
u.jimdo.com/www44/o/s97b1350c762a1a06/emotion/crop/header.jpg?t=1331149688
Martedì 26 luglio (dalle 19:30 alle 21:00) si terrà un Seminario sulla gesticolazione italiana e le sue origini, presso Il Centro Italiano di Madrid, tenuto da Simone Negrin, attore e musicista italiano, dottore in Scienze dell'Educazione presso l'Università di Torino. Vi indico anche il link del suo video: sembra molto interessante e anche divertente! Volete venire?
Simone Negrin (Turín, 1978)
actor, músico y director italiano, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Turín.
Simone Negrin (Turín, 1978)
actor, músico y director italiano, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Turín.
15 jun 2012
Esame sì o esame no?
La settimana scorsa abbiamo avuto gli esami nella nostra scuola (un centro privato dedicato all'insegnamento dell'italiano) e vi voglio raccontare quello che è successo con due alunne di uno stesso gruppo.
Una di loro, quando ha visto le correzioni, dopo un primo momento di delusione si è ripresa e ha colto l'occasione per evidenziare quali punti doveva rinforzare, quindi, è uscita contenta nonostante si aspettasse un voto più alto.
L'altra alunna invece, era molto nervosa il giorno della prova e si è bloccata; infatti, il risultato si è visto: molti errori non frequenti in lei e perfino errori di interpretazione delle istruzioni in alcuni esercizi. Quando ha visto l'esame corretto, è rimasta male e, nonostante le mie parole d'incoraggiamento, è uscita delusa e con un cattivo sapore in bocca.
È ovvio che l'attegiamento della prima alunna è stato molto più positivo ricavando un apprendimento da un brutto risultato; ma è anche ovvio che nelle nostre classi ci sono persone che fanno molta fatica ad accettare un risultato negativo.
La mia domanda (e che rivolgo a voi) è la seguente: è necessario e utile l'esame? Non sono molto sicura della risposta. Cosa ne pensate?
Una di loro, quando ha visto le correzioni, dopo un primo momento di delusione si è ripresa e ha colto l'occasione per evidenziare quali punti doveva rinforzare, quindi, è uscita contenta nonostante si aspettasse un voto più alto.
L'altra alunna invece, era molto nervosa il giorno della prova e si è bloccata; infatti, il risultato si è visto: molti errori non frequenti in lei e perfino errori di interpretazione delle istruzioni in alcuni esercizi. Quando ha visto l'esame corretto, è rimasta male e, nonostante le mie parole d'incoraggiamento, è uscita delusa e con un cattivo sapore in bocca.
È ovvio che l'attegiamento della prima alunna è stato molto più positivo ricavando un apprendimento da un brutto risultato; ma è anche ovvio che nelle nostre classi ci sono persone che fanno molta fatica ad accettare un risultato negativo.
La mia domanda (e che rivolgo a voi) è la seguente: è necessario e utile l'esame? Non sono molto sicura della risposta. Cosa ne pensate?
4 jun 2012
Università Ca' Foscari
Vi volevo consigliare di visitare il sito web del Centro di Didattica delle Lingue, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, all'avanguardia nella ricerca dell'insegnamento delle lingue straniere e nella formazione dei docenti attraverso diversi laboratori specializzati, corsi di laurea, corsi di postlaurea e master. Alcuni dei corsi e seminari sono on line ed altri combinano i corsi virtuali con seminari presenziali (ve lo immaginate due settimane a Venezia...?!). C'è anche la possibilità di condividere e avere accesso a materiali didattici.
Magnifico, non vi sembra? Vi indico il link:
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93979
Magnifico, non vi sembra? Vi indico il link:
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93979
30 may 2012
Senza fretta
Senza fretta, senza la pressione di un obiettivo predeterminato, addirittura senza essere costretti a seguire una programmazione (chiedo scusa agli esperti in glottodidattica!) ma sono sempre più convinta che un progresso reale ed effettivo si possa solo verificare quando l'insegnante segue -semplicemente- il ritmo che gli studenti segnano.
Ieri ho fatto l'ultima lezione prima dell'esame con un gruppo di stdenti spagnoli di livello A2 e non mi è piaciuta per niente; costretta a finire il programma ho dovuto inserire il condizionale semplice negli ultimi quarantacinque minuti! Vi potete immaginare il risultato...
Nella scuola dove lavoro abbiamo molti studenti che non sono interessati a ottenere un certificato e neanche a raggiungere nessun livello prestabilito ma, semplicemente, vogliono conoscere la lingua italiana per i più svariati motivi: perché il figlio o la figlia si è sposato/a con un italiano/a, perché vogliono fare un viaggio con gli amici, perché sono appassionati d'opera o perché è sempre stato uno dei loro sogni. E questo tipo di studente non può imparare sotto la pressione di un programma (del tipo "adesso tocca fare i relativi perché sono nel libro") o un esame dove sarà giudicata - nella maggior parte dei casi- solo la correttezza grammaticale.
Negli ultimi tempi sto verificando che per acquisire e per apprendere una lingua ci vuole indubbiamente da parte dello studente: curiosità e desiderio di avvicinarsi alla lingua e alla cultura oggetto di studio e disposizione a lavorare con altri compagni e con l'insegnante; da parte di quest'ultimo è necessaria innanzitutto una grande sensibilità per capire il gruppo che ha davanti e ognuno degli studenti (ci vuole tanta psicologia!), e deve anche avere il coraggio di rischiare e seguire il ritmo degli alunni senza la pressione di un programma o di un esame e programmare le lezioni sotto questa prospettiva.
Che cosa ne pensate? Avete avuto delle esperienze simili?
Ieri ho fatto l'ultima lezione prima dell'esame con un gruppo di stdenti spagnoli di livello A2 e non mi è piaciuta per niente; costretta a finire il programma ho dovuto inserire il condizionale semplice negli ultimi quarantacinque minuti! Vi potete immaginare il risultato...
Nella scuola dove lavoro abbiamo molti studenti che non sono interessati a ottenere un certificato e neanche a raggiungere nessun livello prestabilito ma, semplicemente, vogliono conoscere la lingua italiana per i più svariati motivi: perché il figlio o la figlia si è sposato/a con un italiano/a, perché vogliono fare un viaggio con gli amici, perché sono appassionati d'opera o perché è sempre stato uno dei loro sogni. E questo tipo di studente non può imparare sotto la pressione di un programma (del tipo "adesso tocca fare i relativi perché sono nel libro") o un esame dove sarà giudicata - nella maggior parte dei casi- solo la correttezza grammaticale.
Negli ultimi tempi sto verificando che per acquisire e per apprendere una lingua ci vuole indubbiamente da parte dello studente: curiosità e desiderio di avvicinarsi alla lingua e alla cultura oggetto di studio e disposizione a lavorare con altri compagni e con l'insegnante; da parte di quest'ultimo è necessaria innanzitutto una grande sensibilità per capire il gruppo che ha davanti e ognuno degli studenti (ci vuole tanta psicologia!), e deve anche avere il coraggio di rischiare e seguire il ritmo degli alunni senza la pressione di un programma o di un esame e programmare le lezioni sotto questa prospettiva.
Che cosa ne pensate? Avete avuto delle esperienze simili?
20 may 2012
Seminario "Lengua y cultura gastronómicas italianas"
Vi voglio informare su un seminario che si terrà a Madrid dal 2 al 6 luglio organizzato dal Departamento de Filologías Extranjeras dell'Uned. Fa parte del programma dei seminari estivi che ogni anno organizza l'università "Cursos de Verano de la Uned". In quest'occasione il seminario è dedicato al linguaggio e alla cultura della gastronomia italiana. Io ho assistito a corsi anteriori e vi posso dire che oltre a essere molto interessanti rispetto ai contenuti, quessti seminari risultano molto gradevoli: l'ambiente è rilassato, si conoscono persone con affinità simili, il rapporto con i professsori è molto cordiale, si va a pranzo e a cena insieme... insomma, prima di andare in vacanza è un modo gradevole e utile di chiudere il corso. Vi lascio qui il link e, se vi interessa, ci vedremo al seminario!http://qinnova.uned.es/publico_actividad/3600
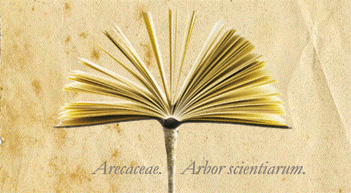 |
|
uned_images06/UNED12_modulo.jpg
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

